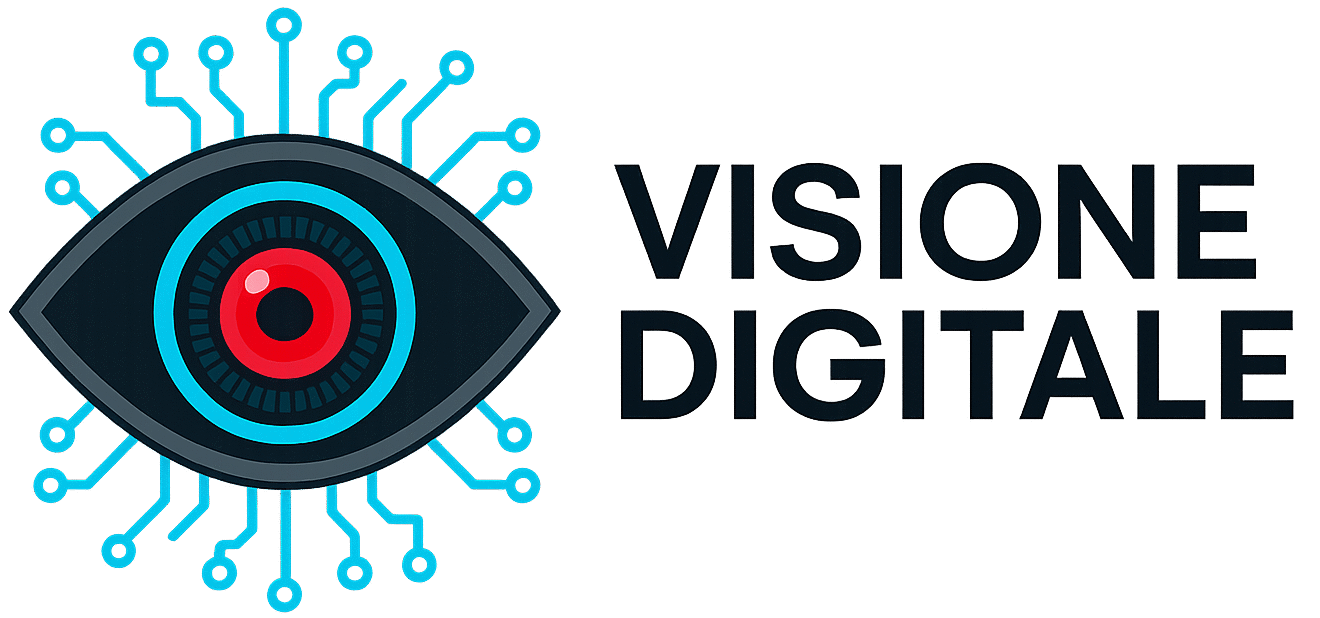Sono passati quasi trent’anni dalla sua uscita, eppure c’è un film che continua a esercitare un fascino disturbante che resiste al tempo, alle mode e persino all’evoluzione del genere thriller. Parliamo di Cure, diretto da Kiyoshi Kurosawa nel 1997 e che non ha bisogno di colpi di scena urlati o di immagini esplicitamente scioccanti per lasciare il segno: la sua forza sta tutta in un’inquietudine sottile, progressiva, che si insinua lentamente nello spettatore e non lo abbandona più. Oggi è ancora sorprendentemente attuale, capace di mettere a disagio con mezzi minimi e con una lucidità rara.
Ambientato in una Tokyo anonima e spenta, Cure prende avvio come un classico poliziesco. Una serie di omicidi efferati sconvolge la città, accomunati da un dettaglio inquietante: gli assassini vengono sempre trovati sul posto, confessano senza opporre resistenza, ma non sanno spiegare perché hanno ucciso. A indagare è il detective Kenichi Takabe, interpretato da Kōji Yakusho, uomo rigoroso e metodico, ma profondamente logorato da una vita privata sempre più fragile. Fin da subito, però, è chiaro che il film non è interessato a risolvere semplicemente un enigma criminale.
Il punto di svolta arriva con l’emergere della figura di Kunio Mamiya, un giovane enigmatico, apparentemente smarrito, incapace di ricordare il proprio passato e di mantenere una memoria stabile del presente. Ogni persona che entra in contatto con lui sembra subire una trasformazione impercettibile ma irreversibile. Kurosawa costruisce attorno a questo personaggio una minaccia che non ha nulla di soprannaturale in senso tradizionale, ma che risulta per questo ancora più angosciante. Cure suggerisce che la violenza non sia qualcosa di esterno, ma una possibilità latente, pronta a emergere se qualcuno è in grado di “scoperchiare” ciò che si nasconde sotto la superficie.
È qui che il film rivela la sua natura più profonda. Il thriller investigativo diventa progressivamente uno studio sull’identità, sul libero arbitrio e sulla fragilità della coscienza. Kurosawa utilizza spazi vuoti, silenzi prolungati, inquadrature statiche e una messa in scena rigorosa per creare un senso costante di disagio. Non c’è mai un momento di vera rassicurazione: anche quando sembra di aver compreso le regole del gioco, il film le sovverte, lasciando lo spettatore in uno stato di sospensione inquieta.
A rendere Cure una delle storie più agghiaccianti mai viste non è tanto ciò che mostra, quanto ciò che insinua. L’idea che il male possa diffondersi come un’infezione invisibile, senza bisogno di costrizioni o violenza diretta, è ancora oggi disturbante. La regia di Kurosawa evita qualsiasi compiacimento, preferendo un approccio asciutto e controllato che amplifica l’orrore invece di attenuarlo. Anche la performance di Yakusho contribuisce in modo decisivo: il suo Takabe è un uomo che indaga sull’abisso altrui mentre, lentamente, rischia di cadervi dentro.
A distanza di 29 anni, Cure non appare affatto datato. Al contrario, sembra anticipare molte delle inquietudini contemporanee, dalla perdita di identità alla paura di una violenza priva di spiegazioni rassicuranti. È un film che continua a turbare proprio perché rifiuta risposte facili e finali consolatori, lasciando allo spettatore il peso di ciò che ha visto. Ed è anche per questo che, ancora oggi, resta uno dei thriller più gelidi e memorabili mai realizzati.
Leggi anche: Dimenticato da tutti, questo sottovalutato thriller vi strascinerà in uno snervante incubo claustrofobico
© RIPRODUZIONE RISERVATA