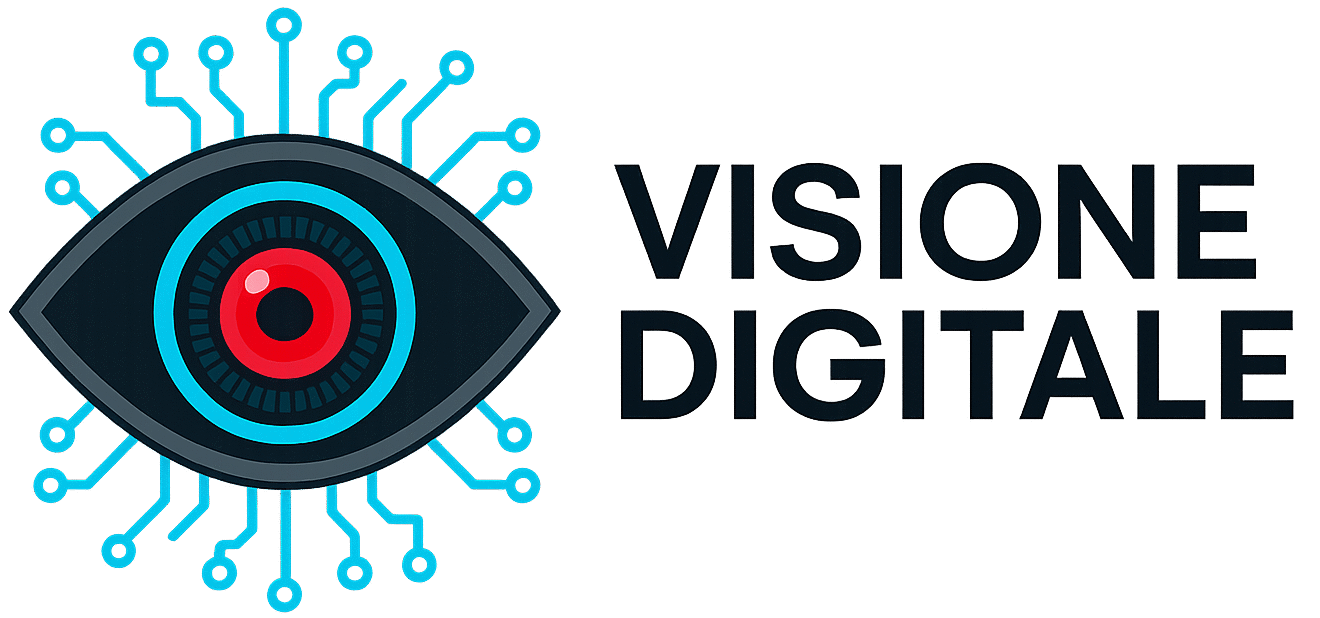Il giorno di San Valentino del 1900, un collegio femminile parte per una gita tra le rocce dell’entroterra australiano. Il caldo è opprimente, gli orologi si fermano a mezzogiorno, il torpore cala come un incantesimo. Tre studentesse e una docente si allontanano e svaniscono. È l’innesco di Picnic a Hanging Rock, capolavoro del 1975 diretto da Peter Weir e tratto dal romanzo di Joan Lindsay: un film che racconta il male e il mistero senza mostrare una sola goccia di sangue, affidandosi alla potenza dell’ambiguità.
Weir mette subito in crisi i nostri strumenti di lettura. Nel collegio Appleyard, incarnazione di una rigida morale vittoriana trapiantata in Australia, la direttrice (Rachel Roberts) tenta di difendere ordine e reputazione alzando muri disciplinari. La polizia cerca indizi, i giornali costruiscono una narrazione, la comunità pretende una verità semplice. Ma Picnic a Hanging Rock non concede la scorciatoia del colpevole o del soprannaturale esplicito: ogni pista apre un’altra domanda, ogni certezza si sbriciola. Il ritorno in vita di una sola ragazza non risolve, anzi peggiora: il mistero resta intatto, la memoria è un’ombra, l’amnesia diventa ferita collettiva.
La messa in scena è la vera chiave. La fotografia lattiginosa di Russell Boyd trasforma la luce australiana in materia sensoriale; i ralenti appena percettibili e il pulviscolo sospeso ci trascinano in uno stato ipnotico. Le studentesse, in bianco, salgono tra i massi togliendosi scarpe e calze: un gesto minuscolo che allude a una liberazione dai corsetti, morali e fisici, imposti dall’istituzione. La natura non è sfondo, è presenza che guarda e forse chiama. La colonna sonora, con i flauti di pan di Gheorghe Zamfir e le partiture di Bruce Smeaton, aggiunge una vibrazione ancestrale che rende l’aria quasi elettrica: non serve vedere l’orrore quando lo si può sentire nell’attrito tra forma e vertigine.
I personaggi si muovono su questa crepa. La signora Appleyard, simbolo di un potere coloniale che vuole addomesticare l’indomabile, si inaridisce fino alla crudeltà. La giovane insegnante di francese (Helen Morse) intuisce in Miranda (Anne-Louise Lambert) un’icona di bellezza pagana, ma ne resta paralizzata. Il giovane aristocratico Michael (Dominic Guard) confonde la ricerca della verità con un’ossessione romantica; il cocchiere Albert (John Jarratt) è l’unico a capire che certe cose non si possono afferrare senza esserne inghiottiti. E poi c’è Sara, la più fragile, che diventa la vittima finale di un sistema che preferisce punire invece di comprendere. Nessuno è “colpevole” in senso classico: tutti partecipano, a modo loro, a un naufragio del senso.
Uno dei meriti più grandi di Weir è far convivere letture diverse senza forzarne una. Il film sfiora l’ipotesi “fantastica” – orologi fermi, animali inquieti, buchi di memoria – ma ne fa soprattutto un’esperienza di spaesamento. Sfiora l’allegoria storica – il dominio britannico che non capisce la terra che vuole controllare – ma non si chiude nella tesi. Sfiora l’educazione sentimentale e la repressione del desiderio – guanti, busti, postura – ma non cerca lo scandalo. È come se Picnic a Hanging Rock ci dicesse che il vero orrore non è l’evento in sé, bensì lo squarcio che apre sulle nostre rappresentazioni del mondo: a volte la realtà non torna, e il cinema può (deve) accettarlo.
Anche per questo il primo terzo del film – la partenza, la siesta, l’ascesa – funziona come un climax rovesciato: una vetta iniziale che il resto del racconto non “spiega”, ma lascia risuonare nelle conseguenze. Le scene successive non rincorrono la soluzione, seguono le onde d’urto: famiglie che ritirano le figlie, reputazioni che si sbriciolano, un collegio che implode. Le immagini ricorrenti – specchi, tende che frusciano, orologi, stoffe che si strappano – sono piccoli campanelli che ci riportano sempre lì, alla roccia, cuore opaco dell’enigma.
Picnic a Hanging Rock resta ancora oggi modernissimo: è un film sul limite del conoscere e sulla paura di perdere il controllo, ma è anche un racconto sulla fascinazione dell’ignoto. Finita l’ultima inquadratura, la roccia continua a incombere nella memoria come una figura impossibile da mettere a fuoco. Non ci sono risposte definitive, ma c’è una certezza: poche opere hanno trasformato il non detto in un brivido così duraturo. Ecco perché, mezzo secolo dopo, il film di Peter Weir inquieta ancora senza una sola goccia di sangue.
© RIPRODUZIONE RISERVATA