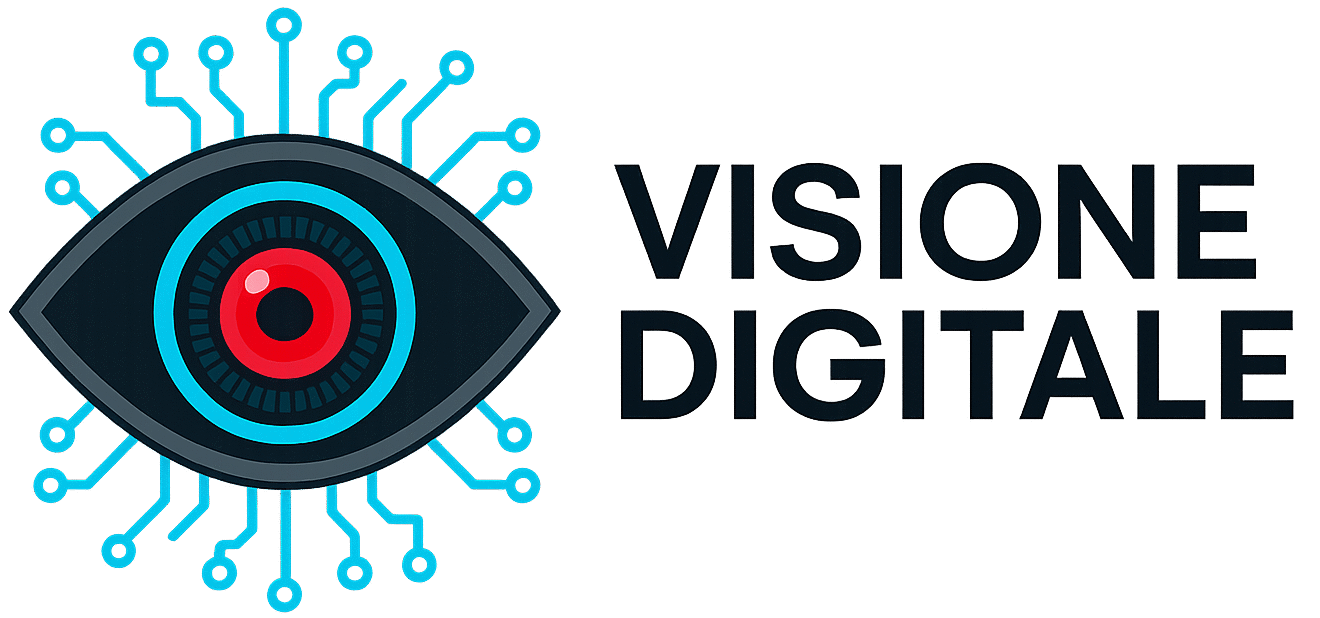Quando Accattone esce nelle sale nel 1961, Pier Paolo Pasolini è già una figura centrale della cultura italiana: poeta, romanziere, intellettuale scomodo, polemista feroce. Ma non è ancora un regista. Fino a quel momento, il suo rapporto con il cinema si è fermato alla scrittura di sceneggiature per altri autori – da Le notti di Cabiria di Fellini a Il bell’Antonio di Bolognini. Il debutto dietro la macchina da presa, però, segna una frattura netta: Pasolini entra nel cinema portando con sé uno sguardo radicalmente nuovo, capace di fondere il realismo più brutale con una tensione poetica e sacrale mai vista prima.
Già il titolo è una dichiarazione d’intenti. “Accattone”, termine del gergo romano che indica un vagabondo, un miserabile, inchioda subito il film a un’umanità marginale, invisibile, esclusa. La storia è ridotta all’osso: Vittorio “Accattone” Cataldi, interpretato da un magnetico Franco Citti all’esordio, vive sfruttando Maddalena, la prostituta che lo mantiene. Quando lei finisce in carcere, il fragile equilibrio si spezza. Vittorio tenta di rifarsi una vita coinvolgendo Stella, ma il lavoro onesto gli è insopportabile. Torna così ai furti, fino a una morte improvvisa e violenta, in un incidente in moto.
Eppure, fermarsi alla trama significa mancare completamente il bersaglio. Accattone non è un semplice racconto criminale, ma un sistema simbolico in cui ogni gesto, ogni volto, ogni spazio è caricato di un peso che va oltre la narrazione. All’inizio degli anni Sessanta, il neorealismo classico sta ormai lasciando il posto ad altre forme: la modernità alienata di Antonioni, il barocco felliniano, la Nouvelle Vague francese. Pasolini sceglie una strada diversa: tornare al reale, sì, ma portandolo a un livello estremo, quasi archetipico.
Le borgate romane in cui ambienta il film – quartieri nati sotto il fascismo e trasformati nel dopoguerra in luoghi di esclusione assoluta – non sono un semplice sfondo. Sono il cuore pulsante del racconto. Pasolini conosce intimamente quel mondo: ci ha vissuto, ha insegnato ai suoi ragazzi, ne ha osservato i riti, il linguaggio, le contraddizioni. Per questo affida i ruoli a volti non professionisti, presi direttamente dalla strada. I loro corpi, i loro dialetti, le loro posture non recitano: esistono.
Ma Accattone non è un documentario sociale. Pasolini parlava di “realismo sacralizzato”: la realtà, colta nella sua forma più nuda, viene elevata a mito. Il degrado non è mai compiaciuto, ma trasformato in icona. È un’operazione che rompe con la neutralità del neorealismo e introduce una dimensione simbolica potentissima.
Ateo dichiarato, ma profondamente attraversato da un senso del sacro, Pasolini utilizza il cinema per cercare una spiritualità che non passa dalla religione istituzionale. Nei suoi film, il sacro si annida nel profano: in un gesto, in uno sguardo, in un oggetto qualunque. In Accattone, Stella non è soltanto una donna, ma una possibile stella-guida, una promessa di redenzione che il protagonista non è in grado di afferrare.
La spiritualità pasoliniana non consola. I personaggi non cercano empatia, ma confronto. I volti, spesso ripresi frontalmente, guardano lo spettatore come se lo interrogassero, lo mettessero sotto accusa. È uno sguardo che non permette distacco.
Anche dal punto di vista formale, Accattone è un film spiazzante. I lunghi pedinamenti, le inquadrature statiche, i movimenti di macchina essenziali trasformano la realtà in qualcosa di più denso della semplice registrazione. La colonna sonora è un altro elemento di rottura: Bach irrompe nella vita delle borgate come un corpo estraneo, creando uno scarto emotivo e simbolico che eleva la miseria quotidiana a tragedia universale.
La morte attraversa tutto il film. È evocata fin dall’inizio e si compie nel finale. La figura di Balilla, che accompagna Accattone nei momenti decisivi, assume contorni quasi metafisici, come un angelo oscuro. Eppure, nel momento della fine, Pasolini compie il suo gesto più radicale: solo nella morte Vittorio diventa davvero “Vittorio”, cioè vincitore. «Ah, mo sto bene», sussurra, come se la pace fosse possibile solo fuori dal mondo.
All’epoca, Accattone non ebbe il clamore di altri capolavori coevi. Gli anni tra il 1959 e il 1963 furono un’età dell’oro irripetibile: Fellini, Antonioni, Visconti, Godard, Bergman, Hitchcock stavano riscrivendo il linguaggio del cinema. Eppure, a distanza di oltre sessant’anni, il film di Pasolini conserva una forza intatta.
Molti registi, in Italia e all’estero, hanno riconosciuto in Accattone un modello: la dimostrazione che il cinema può unire osservazione sociale e ambizione poetica senza addolcire nulla. Con il suo esordio, Pasolini non si limitò a raccontare una storia marginale: inventò un modo nuovo di guardare il mondo. E chiese allo spettatore di fare lo stesso, senza abbassare lo sguardo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA