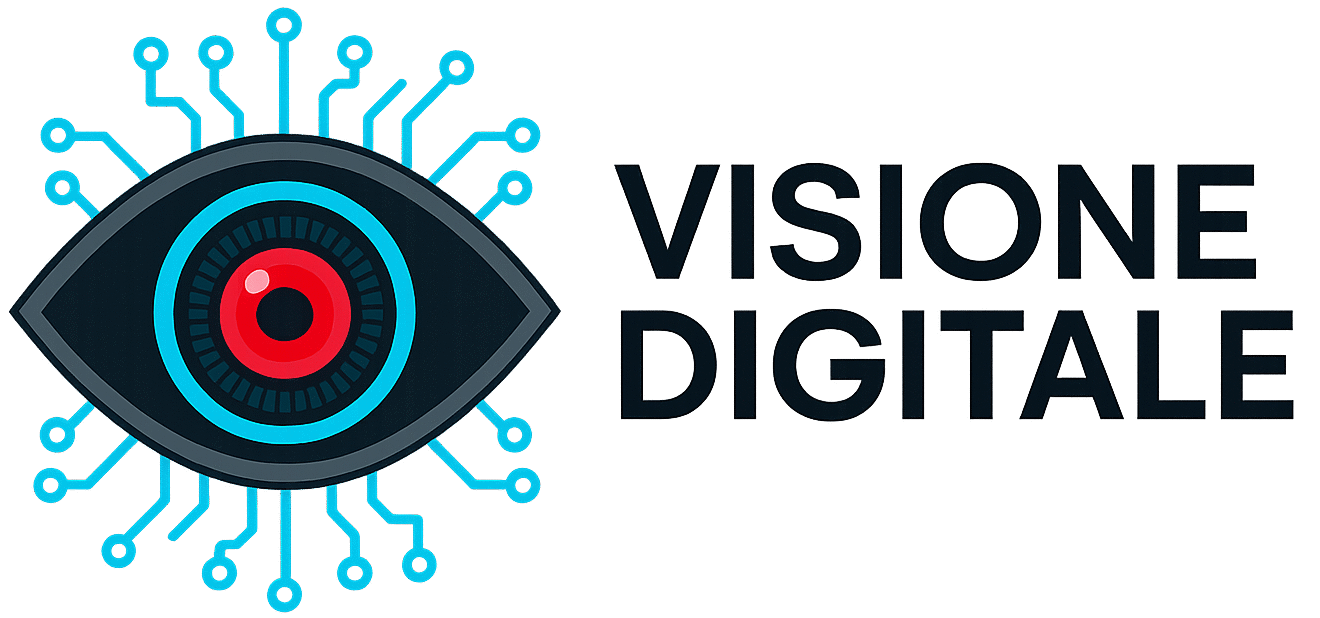A quasi cinquant’anni dalla sua uscita, La croce di ferro resta uno dei film di guerra più duri, anti-retorici e disturbanti mai realizzati. Sam Peckinpah, sceglie un punto di vista rarissimo nel cinema occidentale: raccontare la Seconda Guerra Mondiale dal fronte tedesco, mettendo al centro un gruppo di soldati della Wehrmacht intrappolati in una spirale di ordini folli, ambizioni personali e sopravvivenza istintiva. Non c’è eroismo, non c’è redenzione: solo uomini macinati dalla macchina bellica.
È proprio questo sguardo “dietro le linee nemiche”, spogliato di qualsiasi trionfalismo, a rendere il film uno dei capitoli più radicali e controversi del cinema bellico. Un’opera che all’epoca divise, ma che oggi appare più lucida che mai.
Il protagonista è Steiner, interpretato da un gigantesco James Coburn: un sergente stimato dai commilitoni, considerato una leggenda vivente per la sua resistenza e il suo coraggio. Ma Steiner è tutto fuorché un soldato modello. Disprezza l’autorità, odia la disciplina cieca dell’esercito, sopporta il conflitto solo come un destino inevitabile – un meccanismo crudele che inghiotte uomini senza chiedere nulla in cambio.
Il suo contraltare è il capitano Stransky (Maximilian Schell), aristocratico prussiano, arrivista, pronto a sacrificare interi plotoni pur di ottenere la prestigiosa Croce di Ferro. La battaglia tra Steiner e Stransky non è solo fisica: è uno scontro morale, ideologico, quasi simbolico. Da una parte chi sopravvive nonostante l’orrore; dall’altra chi sfrutta l’orrore per costruirsi un’immagine eroica.
Peckinpah utilizza i due personaggi come poli opposti per raccontare un mondo allo sbando, dove la leadership è marcia, la verità negoziabile e il valore umano irrilevante.
In La croce di ferro ritroviamo tutto ciò che definisce il cinema di Peckinpah: corpi trascinati nel fango, esplosioni secche, sangue e sudore che imbrattano ogni inquadratura. Ma qui la violenza non è spettacolo: è caos, disordine, claustrofobia. Le battaglie sono girate come se la macchina da presa fosse intrappolata in trincea; il fumo e la polvere inghiottono tutto; i soldati diventano sagome che scappano, cadono, urlano.
È un film che rifiuta la lettura epica della guerra: non ci sono vincitori, solo superstiti. E Peckinpah lo ribadisce nell’indimenticabile finale, in cui le risate di Steiner si trasformano in un gesto di scherno davanti all’assurdità della violenza umana.
Se da un lato La croce di ferro è una potentissima esperienza sensoriale e umana, dall’altro sfiora solo superficialmente la complessità morale del raccontare soldati tedeschi. Peckinpah evita accuratamente ogni riferimento esplicito al nazismo, come se volesse concentrarsi sul meccanismo della guerra più che sul contesto ideologico. Una scelta ambigua, che nel tempo ha suscitato dibattiti e perplessità, anche perché alcuni personaggi rischiano di scivolare nel cliché del “buon tedesco”. Adi là di questi tratti che potrebbero essere percepiti come debolezze, il film resta un monumento del cinema bellico: un’opera ruvida, sporca, disperata, che ancora oggi colpisce al petto con la sua umanità ferita.
Rivederlo significa confrontarsi con la follia del potere, con la fragilità dell’uomo, con la violenza come linguaggio universale. Ed è proprio questa sua capacità di non invecchiare mai che lo rende uno dei migliori film di guerra di sempre, nonostante il suo status di opera “dimenticata” o ingiustamente marginalizzata.
Fonte: Collider
© RIPRODUZIONE RISERVATA