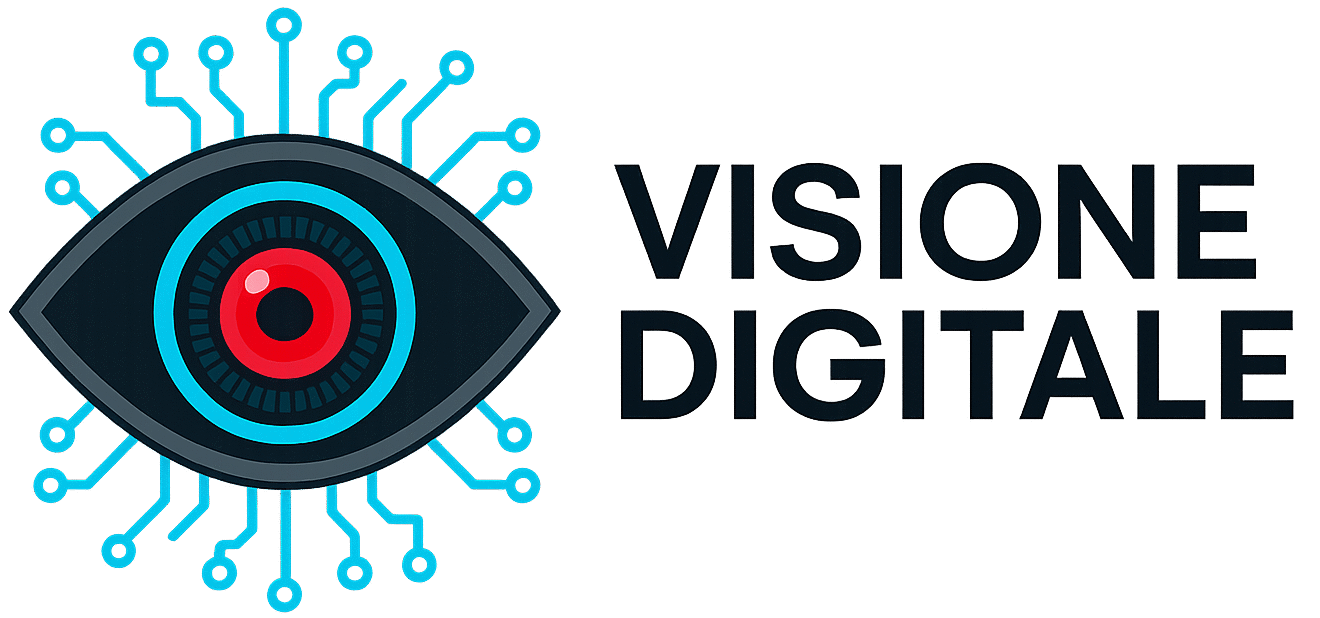A più di vent’anni dalla sua uscita, Mulholland Drive continua a essere citato come uno dei film più disturbanti e destabilizzanti del XXI secolo. Non è un horror in senso stretto, eppure riesce ancora oggi a provocare un senso di angoscia più profondo e persistente di molti film esplicitamente spaventosi. Il motivo sta nella sua capacità di lavorare sulle paure più intime, quelle che non hanno bisogno di mostri o spiegazioni, ma che nascono dalla perdita di identità, dal fallimento e dal desiderio frustrato.
Con questo film, David Lynch porta a compimento un percorso artistico iniziato decenni prima, affinando una poetica basata sull’incubo come stato mentale. Fin da Eraserhead, il regista ha dimostrato di saper trasformare l’ordinario in qualcosa di profondamente inquietante, mescolando surrealismo, violenza emotiva e frammentazione narrativa. Opere come Blue Velvet e Lost Highway hanno progressivamente preparato il terreno, mentre Twin Peaks ha reso familiare al grande pubblico l’idea che dietro la superficie rassicurante della normalità si nasconda sempre qualcosa di marcio.
Mulholland Drive rappresenta il punto di sintesi di questa visione. Tutto nel film sembra funzionare secondo una logica onirica: i personaggi cambiano volto, le identità si sovrappongono, le cause non portano mai a effetti chiari. Lo spettatore viene trascinato in un racconto che sembra promettere una struttura riconoscibile, salvo poi smantellarla pezzo dopo pezzo. È proprio questa instabilità a generare paura, perché priva chi guarda di qualsiasi appiglio narrativo o emotivo.
Al centro del film c’è il sogno di Hollywood, osservato non come promessa di successo, ma come macchina di distruzione. La giovane aspirante attrice interpretata da Naomi Watts arriva a Los Angeles con entusiasmo e ingenuità, convinta che talento e determinazione bastino per emergere. L’incontro con una donna misteriosa e senza memoria innesca una relazione che sembra offrire conforto, ma che presto si trasforma in qualcosa di più oscuro e irrisolto. Lynch utilizza questa dinamica per raccontare un sistema che seduce, illude e infine schiaccia chi vi entra con troppe speranze.
Il film allarga poi lo sguardo, mostrando un’industria governata da forze invisibili e decisioni arbitrarie, dove il controllo creativo è un’illusione e il destino degli individui viene deciso lontano dai riflettori. Tuttavia, Mulholland Drive non si limita a una critica del sistema hollywoodiano. Il suo vero cuore è emotivo: il racconto di una mente che si rifugia nel sogno per sfuggire a una realtà insopportabile, salvo scoprire che anche il sogno può diventare una prigione.
È qui che il film diventa realmente spaventoso. Non per ciò che mostra, ma per ciò che suggerisce. Le sequenze più celebri e disturbanti funzionano perché arrivano senza preavviso e senza spiegazioni, lasciando un senso di disagio che non si dissolve con i titoli di coda. La paura nasce dalla consapevolezza che i personaggi – e con loro lo spettatore – sono intrappolati in un incubo emotivo dal quale non esiste una vera via di fuga.
Nel suo ultimo atto, Mulholland Drive abbandona definitivamente ogni illusione, trasformando il sogno in un confronto brutale con la realtà. Gelosia, frustrazione e dolore esplodono in una delle conclusioni più devastanti del cinema contemporaneo, capace di colpire non tanto per ciò che racconta, ma per come lo fa. È un finale che non offre consolazione, ma che rimane impresso proprio per la sua crudezza emotiva.
Rivederlo oggi significa confrontarsi con un film che non ha perso nulla della sua forza. Anzi, in un’epoca in cui molte narrazioni cercano spiegazioni immediate e chiusure rassicuranti, Mulholland Drive continua a distinguersi come un’opera che rifiuta ogni semplificazione. È questo che lo rende ancora così inquietante: la sua capacità di insinuarsi sotto la pelle e restarci, dimostrando che il vero terrore non ha età e non ha bisogno di essere spiegato per funzionare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA