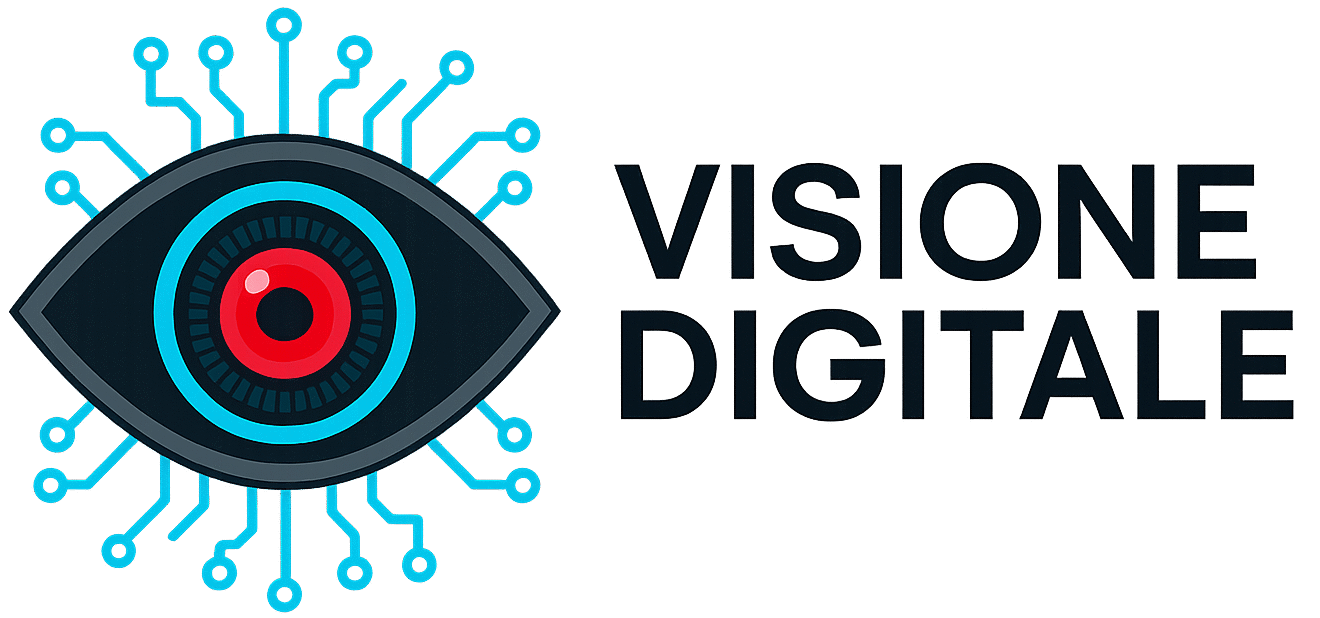Quando Paisà arriva nelle sale nel 1946, l’Italia è un Paese ancora ferito, diviso, in ricostruzione. Roberto Rossellini non prova a raccontare la guerra come un grande affresco eroico o come una semplice cronaca di liberazione: sceglie una strada molto più spietata e, proprio per questo, modernissima. La guerra la spezza in frammenti, la segue lungo la penisola, la osserva dal basso, nei dettagli più piccoli e umani, là dove la retorica non attecchisce. Ne nasce un film composto da sei episodi autonomi, ambientati lungo la risalita degli Alleati dalla Sicilia alla Pianura Padana, che insieme restituiscono un ritratto nudo e potentissimo dell’Italia tra il 1943 e il 1945.
Ogni episodio è un incontro e, quasi sempre, un corto circuito: italiani e soldati americani, lingue diverse, culture che non si riconoscono, religioni che convivono a fatica. Rossellini rinuncia alla continuità classica, alla psicologia “spiegata”, al personaggio che cresce e si compie, e costruisce invece un cinema per collisioni. Non c’è una vera trama unica, ma una progressione geografica e morale: il viaggio dal Sud al Nord diventa una discesa dentro le contraddizioni della liberazione, dove il passaggio dal “prima” al “dopo” non è mai netto. È qui che Paisà resta spaventosamente attuale: racconta la Storia non come racconto ordinato, ma come somma di percezioni, equivoci, ferite, scelte sbagliate o inevitabili.
La modernità del film è anche stilistica. Paisà è uno degli esempi più radicali di quell’amalgama tra documentario e finzione che rende il neorealismo qualcosa di più di una semplice estetica “povera”. Rossellini gira in luoghi reali, spesso devastati dalla guerra, riempie l’inquadratura di strade, rovine, volti non addestrati al cinema. Eppure non è un “reportage” travestito: il reale viene organizzato, ricomposto, reso esperienza. Le città non fanno da sfondo: sono corpi vivi. Napoli con le sue ferite e le sue cavità sotterranee, Firenze trasformata in linea del fronte, la distesa piatta e crudele del Po che inghiotte uomini e speranze. Persino i passaggi che collegano gli episodi, come la mappa dell’avanzata, non servono a rassicurare lo spettatore: servono a farlo sentire dentro un processo storico che non concede pause.
E poi c’è l’elemento che, più di ogni altro, rende Paisà “spietatamente moderno”: il linguaggio. In questo film si parla molto e ci si capisce pochissimo. Inglese, italiano, dialetti locali si sovrappongono, si respingono, creano fraintendimenti continui. La comunicazione, quando avviene, passa spesso dai gesti, dai silenzi, dagli sguardi, dalla prossimità improvvisa tra persone che non condividono parole. Rossellini capisce una cosa che il cinema classico tende a evitare: in guerra la parola non chiarisce, confonde; non unisce, separa. E anche quando sembra aprire uno spiraglio di fratellanza, resta sempre un residuo di distanza, una frattura. È un film che racconta l’incomunicabilità non come “tema”, ma come condizione concreta di ogni episodio.
Dentro questa cornice, la guerra non è un evento astratto: è una forza che altera la vita quotidiana e la percezione dell’altro. Non esiste un punto di vista comodo. Rossellini osserva gli americani come liberatori, sì, ma anche come corpi estranei; osserva gli italiani come liberati, sì, ma anche come individui obbligati ad adattarsi, a sopravvivere, a barattare tutto con tutto. Le relazioni nascono e si sfaldano in pochissimo tempo, spesso senza che i personaggi se ne rendano conto. Il film non insiste sul “sentimento” in modo melodrammatico: lo lascia emergere per attrito, per contrasto, e proprio per questo fa male.
La struttura a episodi diventa una scelta morale prima ancora che narrativa. La guerra in Paisà non permette continuità: spezza. Spezza le biografie, spezza i legami, spezza perfino la possibilità di riconoscersi. Non a caso, uno dei nodi più duri del film è la distanza tra “sembrare” ed “essere”: in un Paese che cambia pelle in pochi mesi, le persone non sono più quelle di prima, e spesso non vengono più viste per ciò che sono. Il film mostra quanto sia fragile l’identità quando la miseria, la paura e la necessità diventano la regola.
E se c’è un elemento che fa ancora discutere, è l’assenza di qualsiasi trionfalismo. La liberazione avanza, ma il prezzo umano cresce. Il finale, ambientato nelle paludi del Po, non si chiude su un momento di gloria, ma su una brutalità condivisa e quasi anonima, senza consolazione. Rossellini rifiuta il conforto della “vittoria” come chiusura narrativa: preferisce lasciare lo spettatore con la sensazione più vera e più scomoda, quella dell’incertezza. Chi attraversa la guerra non sa mai se ciò che sta facendo “servirà”, se il dolore avrà un senso, se la storia li ricorderà.
È questo che rende Paisà ancora vivo: la sua capacità di tenere insieme contraddizioni profonde senza risolverle. Fraternità e violenza, speranza e disperazione, solidarietà e incomunicabilità. Rossellini non costruisce un messaggio pacificato: costruisce un’esperienza. Non “spiega” la guerra, la fa sentire. Non la trasforma in mito, la restituisce alla sua materia più concreta: corpi, fame, paura, pietà improvvisa, crudeltà altrettanto improvvisa.
A quasi ottant’anni di distanza, Paisà continua a colpire perché non appartiene al passato. Il suo modo di raccontare il conflitto come frizione tra culture, di mostrare l’incontro (e lo scontro) tra mondi che non parlano la stessa lingua, di mettere in crisi l’idea stessa di comunicazione, parla direttamente al presente. È un film che non chiede di essere “ammirato”, ma attraversato. E proprio per questo resta una delle opere più radicali e necessarie del cinema italiano sulla guerra: non per ciò che racconta, ma per come ci costringe, ancora oggi, a guardare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA