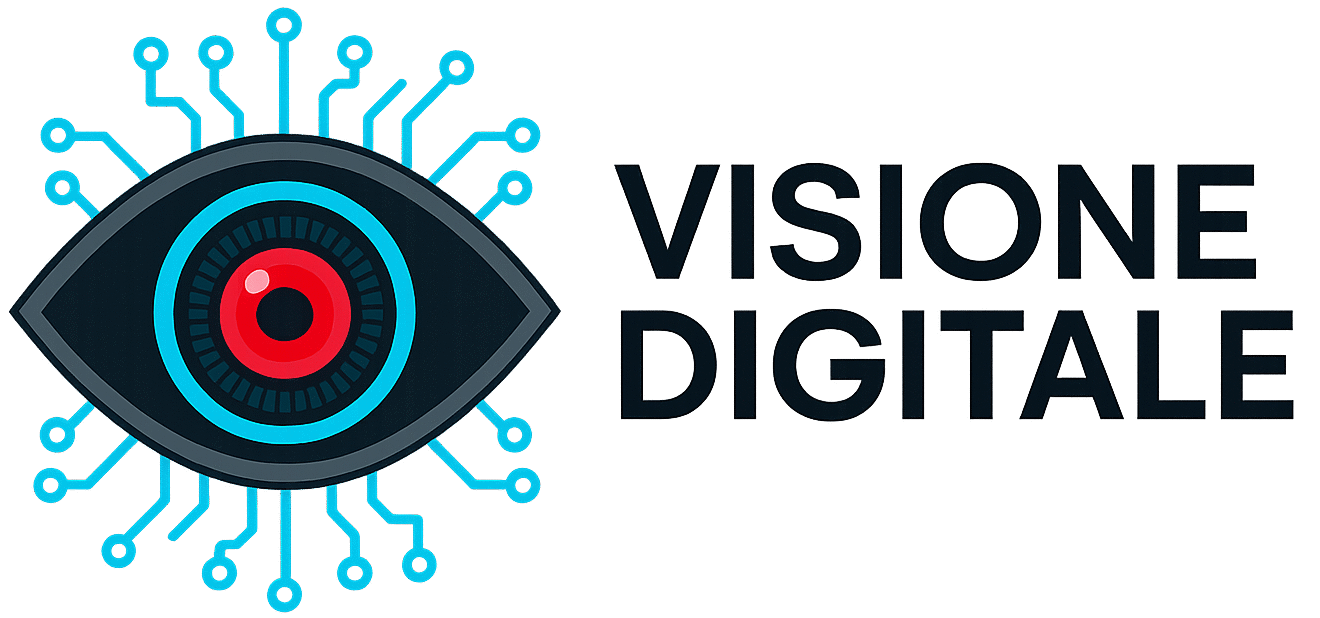Ci sono opere che non si limitano a raccontare una storia: aprono una soglia. Tropical Malady (2004) di Apichatpong Weerasethakul, Premio della Giuria a Cannes, è una di quelle esperienze rare che ti obbligano a ricalibrare lo sguardo. A vent’anni dall’uscita resta un enigma lucente: romantico e selvatico, spirituale e terricolo, sospeso tra due metà che non si ricompongono mai del tutto e proprio per questo continuano a vibrare nella memoria dello spettatore.
Il film si sdoppia senza strappi. Nella prima parte seguiamo l’incontro fra Keng (Banlop Lomnoi), soldato in licenza, e Tong (Sakda Kaewbuadee): piccoli riti quotidiani, luci al neon, karaoke, una città che pulsa di rumori e intermittenze. La messa in scena è limpida, i movimenti di macchina sono discreti; l’atmosfera è luminosa, persino giocosa, e lascia filtrare, a sprazzi, un’altra dimensione: parabole, leggende, accenni di reincarnazione, una caverna che promette un passaggio riservato ai “benedetti”. Il cinema, qui, non spiega: evoca. Al centro, un gesto tenero e animalesco che suggella un patto e annuncia la metamorfosi.
Poi la frattura: il buio. Tropical Malady si reincarna nella selva. Stesse presenze, ma forse nuovi corpi; stessi desideri, ma espressi in un alfabeto diverso. La foresta diventa teatro di apparizioni: un soldato che insegue una creatura imprendibile, la traccia di un felino, l’eco di uno sciamano. Le parole quasi scompaiono e restano i suoni, il vento, gli occhi nella notte. È il gesto più radicale di Weerasethakul: spostare il conflitto dall’ordine del racconto a quello del mito. L’amore abbandona la cronaca e si fa rito di riconoscimento, caccia e offerta, domanda e risposta tra umano e non umano. L’inquadratura smette di illustrare e inizia a convocare forze: non si cerca più il significato, lo si attraversa.
Riguardato oggi, Tropical Malady parla con chiarezza di un mondo diviso fra modernità e tradizione, fra città e giungla, fra l’ordine rassicurante dei simboli e la loro esplosione sensoriale. La prima metà fotografa un presente globalizzato, dove persino l’uniforme può diventare un costume da indossare per convenienza; la seconda restituisce al desiderio una grammatica arcaica, quasi primordiale. Ma ciò che conta non è l’opposizione: è il cortocircuito. Il film non “spiega” la mitologia con la psicologia né riduce la psicologia a folklore: lascia che le due dimensioni si specchino e si contraddicano, finché lo spettatore non è costretto a cambiare postura.
La regia lavora per sottrazione: piani fissi che durano quel tanto che serve a far emergere il fuori-campo, avvicinamenti impercettibili, un uso del suono che crea spazio più che riempirlo. Anche quando sfiora la cronaca — soldati, pattugliamenti, corpi trovati ai margini del bosco — Weerasethakul rifiuta la chiave realista e cerca la vibrazione: il dettaglio che non torna, la “terribile simmetria” di cui parlava Blake, la natura che non fa da sfondo ma detta le regole.
La lettura politica c’è: nella giungla come frontiera della trasformazione, nel corpo che sfugge alla disciplina dell’istituzione, nell’amore che diventa sfida a una norma più ampia della morale privata. Ma l’autore non fa mai saggistica; preferisce immagini madri che si depositano e fermentano. È un cinema che chiede partecipazione, non complicità: non ti accompagna con spiegazioni, ti dà una torcia e ti invita a entrare nella caverna. Qualcuno si fermerà sulla soglia, irritato dall’opacità apparente della seconda parte; eppure è proprio lì, quando il linguaggio arretra, che l’esperienza si fa più tangibile, quasi fisica.
A distanza di vent’anni, Tropical Malady conserva una qualità rara: rimanere intatto pur cambiando con noi. A ogni visione i due movimenti — il giorno urbano e la notte selvatica — sembrano scambiarsi il ruolo, come se l’amore fosse davvero un animale che ci bracca e ci mette alla prova. Non resta una morale, ma una traccia sensoriale: la luce che si spegne all’ingresso della grotta, l’attesa di un ruggito forse immaginato, una mano che sfiora un’altra mano e ne coglie l’odore. Il cinema può ancora toccare l’invisibile: Tropical Malady ne è la prova.