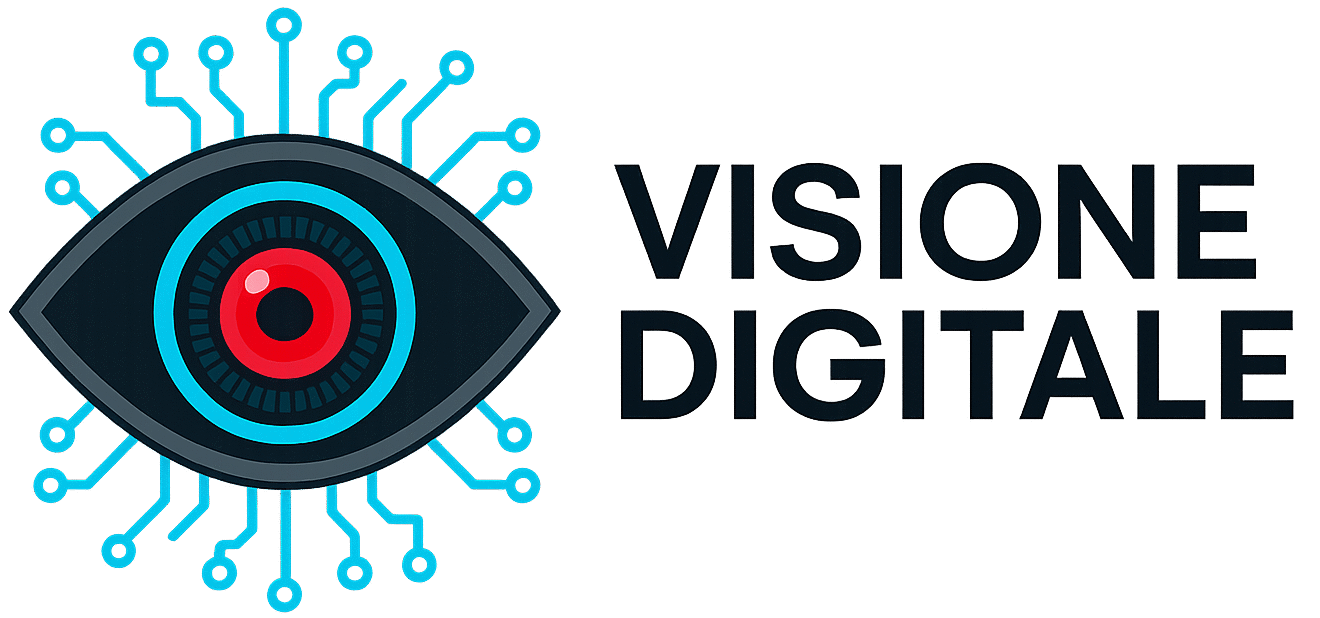[ad_1]
C’è una regola non scritta, una regola che diremo della prudenza, che il critico che ama parlare dei generi musicali più rumorosi osserva per non finire come quelli che “purché faccia casino” va bene tutto. È una regola che sviluppiamo su una serie di piccoli dettagli che non vi starò a dire, ma che permettono di capire se il messaggio arriva a destinazione, con sufficiente chiarezza, o è soltanto un vociare confuso che tenta di farsi sentire nel marasma generale del suddetto casino. Insomma, aria fritta.
Un gruppo delle volte è talmente preso nel considerarsi artistico, eccentrico, il più matto di tutti (e chi siano poi ‘sti tutti non è dato sapere), avvolto nelle sue convinzioni e nei suoi deliri, che si dimentica di fare centro anche solo in una canzone. Dimenticandosi di assicurarsi un punto uno dove andare a parare. Tanto più che, fatevene una ragione, molto di quello che c’è in giro ha molta meno senso d’esistere, perché c’è già, o perché “è già stato scritto dai Fall”, come dice qualcuno di mia conoscenza. Addizioni che formulano gli stessi risultati non son spesso che tentativi di afferrare per i capelli risultati che il giornalista o il critico musicale ha già sentito miliardi di volte e, anche se non ve lo dice per gentilezza, ne ha fin sopra i capelli.
In questo caso bisogna scegliere l’espressione migliore ed elaborarla ulteriormente. Come sanno fare bene i ragazzi dei Mondaze e dei Madbeat. I primi tornano con due singoli dopo quel piccolo miracolo che fu Late Bloom nel 2021, e sia Son Of A Rambling Dawn che la futura traccia-titolo, Linger, odorano magnificamente di quell’aria che si respirò nell’estate del ’93 quando gli Slowdive pubblicarono Souvlaki e, dopo essere stati torturati dal ciclone grunge, Rachell Goswell e Neil Halstead ricordarono a tutti gli stimoli dolci e profumati di immaginazione libera che ci stavamo scordando. Allo stesso modo i quattro faentini aggiungono due paragrafi notevoli allo storytelling di sentimenti e umori del nostro tempo, con un suono devoto ma libero da ogni canone.
I Madbeat, invece, si schiodano in tempo record la nomea di piccoli Bull Brigade con un singolo, I fiori della Palestina, che unisce unsingalong finalmente politico anche al di fuori dalle mura di Torino con un grano di ruvido cipiglio “pop” (virgolette). Azzeccato, specie per un messaggio che tardava ad arrivare e merita di non rimanere esclusivamente “cosa nostra”. E se il cielo apprezza già le specialità indie/Oi! dei quattro, non è giusto che siano altre le ricette che vanno per la maggiore nei fast-food di questa valle di lacrime.
Chi poi vuole evitare cliché non deve limitarsi alle sole aspettative del potenziale uditore se non vuole cadere nella civetteria volgare della auto-referenzialità. Questo è il caso di Urali – ovvero Ivan Tonelli, chitarrista riminese membro di Shelley Johnson Broke My Heart e Cosmetic – dei Preferisco Ignazio e degli Ottone Pesante. Armati tutti di badilate di umiltà tirano fuori tre lavori che ci dimostrano come per anni ci siamo messi la canottiera perché i tempi stavano per cambiare e invece abbiamo solo speso fiumi di parole fra di noi (che prima o poi ci portano via…), quando i temerari che sanno che il segreto è nel rallentare le unità di produzione senza perdere lo stesso nulla della propria capacità schiantarsi, anche solo per vedere l’effetto che fa, sono solo tre.
Qua c’è poco da scherzare, se come dice quel tale che scrive sul giornale per finire sugli articoli che contano bisogna indossare una maschera, simbolica o meno, e non sfilarsela più per avere più carisma e sintomatico mistero. Invece, I Forgot About The Plains di Urali scardina le coordinate di obliquo indie-rock dalle tinte psych e pop e crea un delizioso cadeau a Mike Kinsella e a Marz Kozelek, oltre a una suggestione sonora chamber-folk che ricorda Kimya Dawson o, puntando alto, Elliot Smith.
I Preferisco Ignazio, invece, con il proprio EP partono da un titolo che sa di battaglia (Stendardo) e una traccia d’apertura (Bonaparte) che fa pensare a un gruppo da stadio o che a quello aspira, ma sfocia un fiume di incertezze per il presente, figuriamoci per il futuro. Sono cinque e giovanissimi, ma recriminano un’esistenza troppo veloce, protestando contro gli estenuanti ritmi di una vita che non ci ripaga mai abbastanza. In mezzo ci buttano anche il sesso, riferimento giovanile per un godimento immediato, ma che visto da vicino crea ansie e disillusioni. Sono cinque ballate palpitanti di emo-core, dense però di invenzioni melodiche e altrettanti rimandi altri al indie, al post e al mega-peso. Stendardo è una catapulta con un atterraggio esaltante. E loro vibrano e non nascondono l’entusiasmo di un felice primo traguardo raggiunto.
Infine, se c’è stato un tempo in cui agli Ottone Pesante veniva accusata un’attitudine più festaiola rispetto ad altre band con dei fiati (ZU, Fire Orchestra, Sax Ruins, eccetera), Scrolls Of War è qui per dimostrare l’esatto contrario. Sono un altro gruppo che ha vissuto altre cose, forse più incline a vomitare sul mondo, e meno propenso, se vogliamo, ad accettar la fascinazione verso un certo tipo di sberleffo, di parodia e ballo del ridicolo. Al di là della traccia narrativa/storica di cui leggerete sicuro in ogni dove fino allo sfinimento, è un bisonte per cui non vi basterà l’effervescente Brioschi per dormire placidi. Attenzione. Trattasi di un disco così peso che potrebbe entrare nelle grazie non solo di un Mike Patton ma persino di un Mick Harris. Ciò dovrebbe già bastare per buttarvi a capofitto su queste tracce di brass-metal, avant-jazz e post-hardcore, se avete presente come e quanto i suoi progetti (e gli Scorn, in questo caso, prima di tutti) hanno segnato con peculiarità nuove pagine nei capitoli del rumore. Scrolls Of War ha tutto il rigore e la credibilità per essere un disco licenziato dalla Ipecac o dalla Earache – e risollevarle, se si pensa soprattutto delle recenti poraccaiate di Dave Lombardo e mogliettina – ridefinendo, ancora una volta, le coordinate della ascoltabilità.
Diversi ma affini, gli OvO si uniscono ai Rotadefero per interpretare Il secondo coro delle lavandaie, uscito in questi giorni in vinile split 10″ e su Bandcamp: due differenti versioni di una canzone di antiche radici, già usata per uno spettacolo teatrale di fini anni Settanta e rivisitata e rivissuta da due nomi enormi nel panorama sperimentale nazionale. Il brano viene prima destrutturato e assimilato (Ovo: Covo delle Lavandaie e Rotadefero: Lavanderiadefero) e poi ristrutturato in una versione comunitaria, sempre con l’aiuto di due voci della cultura canora partenopea, Dominga Colonna e Tiziana Carnevale. Il risultato è qualcosa di prezioso, che negli anni verrà di certo ricordato dai fan più attenti.
Difficile quindi restare calmi e indifferenti mentre nessuno intorno presta ancora attenzione al rumore che ascolta, se siamo ancora un po’ tutti in piena Prima Repubblica, e si cerca ancora il consenso con le le tempeste in ‘na tazzulella ‘e caffé. I Dear Bongo, per dire, trovando evidentemente diletto a non far sapere quanto è buono il cacio con le pere, e le recensioni se le scrivono da soli, borbottando di quei due scemi (e uno sono io) che ne hanno parlato e bene. Si dicono più jazz e funk che garage e punk, buttano in mezzo Zappa, Albini e ci risparmiano per un soffio Jim Morrison e Madre Teresa di Gallura. Non è vero manco dipinto ed è un peccato, perché il loro nuovo Unfullfilled trasuda Spaceshits, Gun Club, e Flash Eaters – con un mezzo plagio di The 13th Floor Elevators da scovare – che metà basta. Ma, a una certa, cazzi loro.
Allora, se tanto mi da tanto, preferisco esser tuono come fu Lester Big Bangs e premiare chi, al vecchio gioco del pisello più lungo caro a chi poi da l’8×1000 alla chiesa cattolica, ha le palle per citare chi non cita nessuno, come Ivan Graziani, e che è stato sul serio tutto prima di te. In modo subliminale, si capisce. È il caso dei Vintage Violence e degli Amanti di Nefasto e dei loro rispettivi nuovi singoli, I Non Frequentanti e Zolfo. Entrambi caratterizzati da chitarre notevoli e cantanti dall’inconfondibile voce scomoda e sottile, sia i leccesi che i capitolini dimostrano che la vena melodica può convivere brillantemente con l’indole punk (i primi) e metal (i secondi). Come il cantante dalle montature invadenti ha scritto quaranta e rotti anni fa. A farsi apprezzare è soprattutto il songwriting monello e imprevedibile, che oscilla tra sberleffo e malinconia, e dosa romanticismo naif, evocatività e toni energici, in un bislacco ma riuscito equilibrio tra leggerezza a ironia.
Tra i singoli più fedeli alla linea anche quando la linea non c’è, invece, vi invito a dare una sentita a: If a Comet Strikes the Earth dei The Ammonoids, primo estratto di onestissimo e piacevolissimo pop punk statunitense alla vecchia (devo fare i nomi?) del EP in uscita a novembre; Bombe di Casx che, un po’ come gli altri singoli pubblicati dalla giovane Arianna, sa di midwest emo e di dream pop e ora sarebbe anche il caso di uscire il disco prima che la cosa diventi davvero snervante; First Flight In Planet dei Gotho che, dopo un primo singolo non proprio catalizzante, si riprendono con un mix interessante tra i compianti Zeus e zZz; Things You di Giorgia Piva, in arte Georgia, Georgia, abile a occupare il vuoto occupato dalle Boygenius (e presumibilmente non solo) che in Italia ancora non era stato preso: se queste sono le premesse, il disco prossimo venturo potrebbe essere un saliscendi emotivo assai notevole; infine l’omonimo dei Buscemi’s Eyes, la band con membri di Disordine, Discomostro, Zheros e LeMartire dedita a un movie-hardcore “tarantiniano” a presa così rapida che premi play e sei già morto.
—
L’articolo Il recappone #7: le migliori uscite punk (e dintorni) delle ultime settimane di giorgiomoltisanti è apparso su Rockit.it il 2024-11-12 10:17:00
[ad_2]
Source link