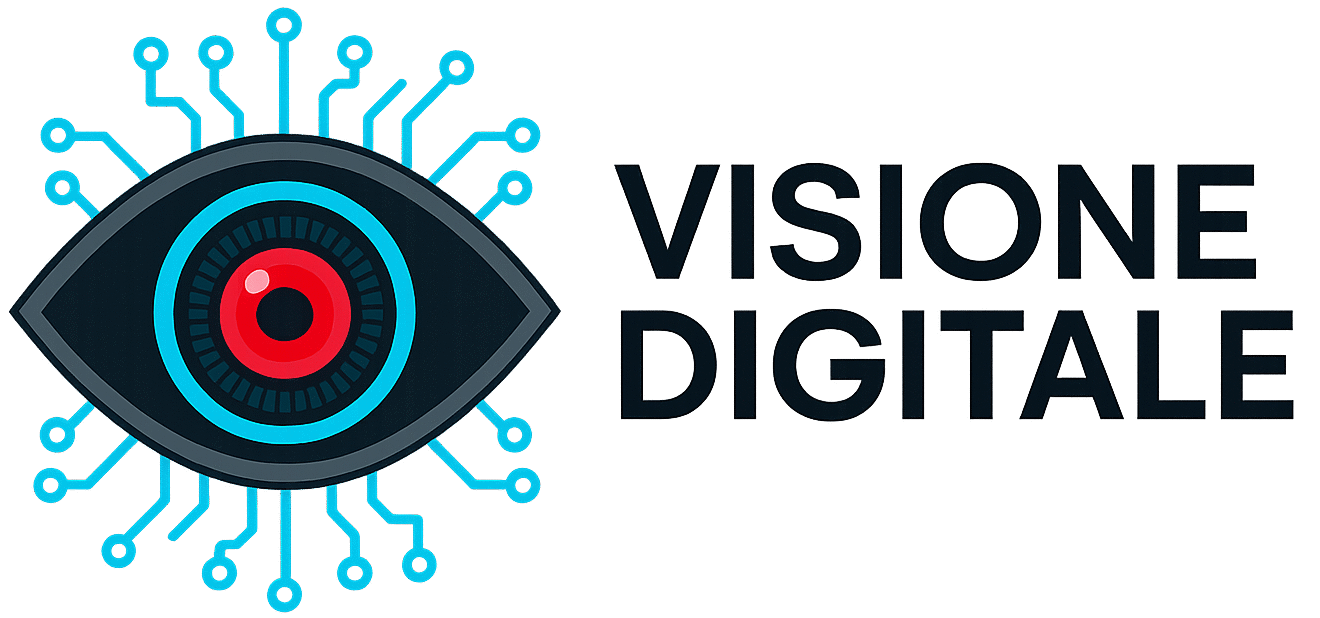[ad_1]
Cita stravaganti ascendenze Carlotta Sillano, dovendo nominare le proprie parentele musicali: oltre quelle più citate in sede di recensione (ovvero Tori Amos e Björk) e che lei ha potuto vivere solo di rimbalzo, essendo nata a Vercelli quando entrambe avevano almeno un disco già all’attivo, le più ricorrenti riguardano la musica impressionista (Debussy, Ravel) e altre cose dell’inizio secolo scorso (Kurt Weill, Edith Piaf).
Viceversa, quando era in studio per questo quarto capitolo della sua discografia, Nella natura vuota dei simboli appassiti (Incipit/Egea, 2024), dice di essersi sentita molto vicina ad Arca e Caroline Polachek, ma anche a Mango (padre) e Milva. Non prima di avere riscoperto Foreign Affair – una canzone di Mike Oldfield del 1983. Ecco, una delle cose facili da apprezzare nella storia di colei che un tempo si faceva chiamare Carlot-ta e ora è diventata Carlotta Sillano, ipotizzo con le stesse motivazioni per cui Guè a una certa non s’è sentito più tanto pequeño, è l’approccio intelligente, a tratti aulico, con cui si rapporta alla musica.
Un approccio intellettuale, se vogliamo, ma senza essere snob, radical chic o prosaicamente stocazzista (chi ha detto Morgan?). Un approccio che le ha permesso di debuttare in sordina con Make Me a Picture of the Sun (Anna The Granny, 2011), nonostante maneggiasse già a vent’anni scritti di Emiliy Dickinson e di William Blake (come gli Ulver, non so se ci capiamo) o musiche di Nino Rota. Il che desta meraviglia, oltre che per la sua intrinseca peculiarità, nella capacità di dare uno spessore a ciò che crea. Riuscendoci anche laddove sembrerebbe impossibile (cercate la cover mondocanesca di Troppe volte di Bobby Solo), e non solo laddove sembra perfino scontato. “In generale mi piace la musica capace di rivelare, evocare ed essere veggente”, sintetizza lei. “Detesto le canzoni che descrivono la quotidianità e ne nominano i suoi aspetti più pratici, banali e generazionali”.
Se poi né questo né quello vi aiuta a capire quale sia il cammino stilistico intrapreso dalla artista piemontese, non vi preoccupate: è normale. Anzi, aggiungeteci pure che tra le fonti d’ispirazione non musicali cita La Pimpa, Emily Dickinson e Lars Von Trier (“Una risposta che sembra data per stupire, ma è sincera!”, aggiunge) e il quadro generale dovrebbe essere ingarbugliato quanto basta per volere sbrogliare il bandolo della matassa prima del termine della lettura.
Lo stile di Carlotta Sillano è uno dei pochi che non è mai stato acerbo, come una salsa o un cocktail calibrati male: come quei gruppi in cui rock, pop e folk si sommano senza gravitare intorno a una definita identità espressiva, in modo casuale, e che di solito finiscono per farsela dare (male) a X Factor. La sua musica ha sempre avuto un suo personale quid, nonostante un’intrinseca fragilità e un’immagine pubblica che non ha mai compreso l’idea di creare un “personaggio”, come pure un’inguaribile iconoclasta come Sinead O’ Connor (“il Bambi con gli anfibi”) preferì fare fin dal primo disco.

Riconoscibilissima, straordinaria nella sua essenza raffinata e fiabesca, senza discussioni tra gli esempi di chamber folk più belli che abbiamo in Italia, la voce. “Se ne parliamo come di uno strumento fatico a considerarmi una cantante, io mi ritengo piuttosto una musicista, anche se poi, dato che scrivo canzoni, ad arrivare per prima è la voce”, dice lei. “Io la trovo un po’ ingenua e incontrollata a volte, ma piuttosto espressiva. Mi dicono tutti che è diversa quando canto, rispetto a quando parlo. Penso sia vero”. Voce che in questo disco sentiamo cantare in italiano.
Ora, io sono troppo vecchio per ritenerlo straordinario o imprevedibile, ma, più che altro, è interessante parlarne come scelta delle parole, come significato e come suono, per come è evidente fin dalle prime tracce. “Semplicemente a un certo punto mi è interessato fare un disco in italiano, mettendo proprio al centro il linguaggio, come giustamente hai notato. In questo senso non è un disco minimale, direi piuttosto complesso e stratificato, ma anche diretto. Più che una predeterminazione delle singole parole, c’è una scelta di tono, un linguaggio letterario, con tutto il repertorio di rime e allitterazioni. I temi riguardano per lo più il tempo e i dispositivi della memoria, di cui fornisco una nutrita rappresentazione: monumenti, collezioni, rovine, icone. Questo è il campo semantico in cui mi sono mossa e in cui ho trovato un lessico che m’interessava usare per raccontare qualcosa di molto soggettivo”.
Affascinati torna la voglia di vivere a un altra velocità e, continuando il gioco delle analogie, altri nomi vengono in mente: Diamanda Galàs (lo spiritualismo pagano), Kate Bush (l’alterità), Joanna Newsom (lo scettro naif) e anche Natasha Khan alias Bat For Lashes (i chiaroscuri). Non sappiamo, tuttavia, quanto valga a individuare meglio la natura artistica di Carlotta. Forse inoltrandosi in aree dominate da altre Muse e cercando in esse un simile specifico si può fare di meglio: che ne dite di Emily Brontë, Agota Kristof, Isadora Duncan o (più recentemente) la Maria Stepanova di Memoria della memoria, tutti caratteri ispirati – diremmo – alla stessa fonte di passionalità emotiva, curiosità conoscitiva e volubilità espressiva a cui attinge anche Carlotta?
Oppure, la soluzione dell’enigma è concentrarsi solo sul soggetto dell’indagine. Il suo fare musica è sempre stato estremamente cinematografico. Roger Corman diceva, e Martin Scorsese gli dava ragione, che in un film quel che conta sono i primi 11 minuti, perché la gente vuol sapere cosa sta succedendo, e gli ultimi 11 perché la gente vuole sapere come va a finire. Quello che è in mezzo non conta molto. Al di là della provocazione (di cui questo album in italiano dopo tre in inglese può esser assieme prova e smentita), interessante è capire come si sia sviluppata la tracklist, sia in senso complessivo che durante la creazione. “Vanitas è la prima canzone che ho scritto, infatti il suo incipit è quello che dà titolo all’album. La canzone descrive una sorta di apocalisse climatica, piuttosto cinematografica in effetti, nomina o cita qualche film, come La quinta stagione, Midsommar, o meglio il racconto La lotteria. È anche il brano più narrativo. La tracklist è quindi una sorta di suite che insegue questa traccia, senza un racconto lineare, ma istintivo, che alterna momenti più leggeri ad altri più drammatici. Per queste ragioni forse hai sentito odore di pellicola. Mi piacerebbe quindi che anche gli 11 minuti di mezzo fossero ascoltati. Penso sia un album da ascoltare nell’insieme, che parte più misterioso, diventa inquieto e poi si schiarisce un po’”.
Sicuramente importante sarà stato anche il percorso di studiosa, prima come dottoranda, poi come appassionata e creatrice di progetti connessi al tema del rapporto tra suoni e luoghi geografici. Anche questo un aspetto stimolante del suo essere e atipico, visto che ormai se non vieni dalla strada e non hai studiato all’Università della vita sembra tu non possa avere il pedigree del vero artista. A meno tu non sia Max Casacci, e allora lì vale tutto, pure fare antropologia con una laurea in chimica. “Sì, sono al massimo una ragazza di periferia, ma una periferia ben collegata. Una backstory poco accattivante. Oltre la musica, cerco di approfondire altri aspetti. Gli studi e il lavoro di ricercatrice mi permettono di imbattermi in temi, luoghi e contesti che spesso sono lontani dal mio mondo, e difficilmente potrei conoscere altrimenti. Mi interfaccio con persone che mi aprono porte su argomenti inaspettati. A volte li abbandono, altre volte me li porto appresso e li approfondisco come qualcosa di importante, che ritorna anche nelle mie canzoni”.
Tutte cose che, come intuibile, traspaiono sentendo il disco fin dalla prima nota e vi faranno chiedere “E questa ora come la catalogano? Dove la infilano?”. Soprattutto in un momento storico in cui crew e brotherhood e (chiamiamole anche) conventicole spopolano, Carlotta gioca la parte della outsider per davvero. Le ci scherza su e mi cita Trucebaldazzi (“La mia gente vera è la gente negativa”) ma poi aggiunge con una concretezza invidiabile: “In realtà mi piace frequentare i miei amici e sono negata a far finta di averne altri, un atteggiamento che mi indispone moltissimo. Secondo me, il futuro è nelle mani delle Pro Loco. La sola crew di cui mi sento davvero parte è la Pro Loco Civiasco, con cui organizzo anche un festival piuttosto surreale (il festival di musica e di narrazioni La notte del re Di Biss, in Valsesia, nda). Se parliamo di classificazione invece, non è mio compito, ma mi piacerebbe non essere fraintesa, e non sono sicura sia una cosa che mi viene sempre bene”.
Verosimilmente ha qualcosa a che vedere, l’indeterminabilità del suo essere artista, con la condizione della donna nel mondo dello spettacolo e dell’arte: difficile, sì, ma foriera a volte di nuove ipotesi e intuizioni. Proprio come nel suo caso. “Io mi chiedo se, come dice St. Vincent, da uomo sarei stata la stessa, sia se sarebbe stato lo stesso essere un uomo, due prospettive leggermente diverse. Non so a quale facesse riferimento lei, che mi risulta essere in ogni caso un ottimo modello di artista e di donna nel mondo dell’arte. Penso comunque sia ancora un tema di cui è interessante parlare anche soltanto per questo, per capire bene quali sono le sensibilità altrui, considerare nuove prospettive, indagare, fare presente”.
Ecco, Carlotta è così, una per cui il successo e tutto ciò che ha ottenuto e otterrà dipende dal fatto che sa pensare, oltre che comporre e cantare, e queste non sono qualità che possono essere date dall’industria discografica o, per osmosi, frequentando chicchessia. Certo, sa di fare musica, ma non è certamente disposta a giocare al gioco dello showbiz come molti aspirano a fare.
—
L’articolo La mia crew è la pro loco di giorgiomoltisanti è apparso su Rockit.it il 2024-11-18 10:14:00
[ad_2]
Source link