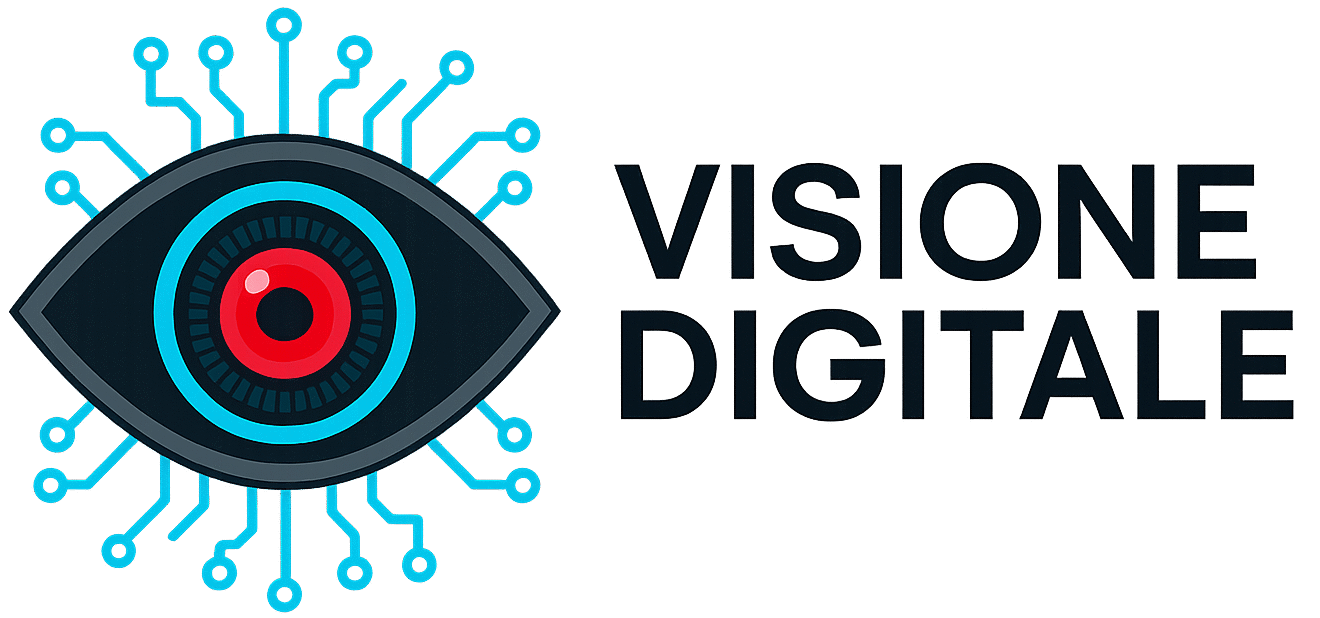A oltre 20 anni dalla sua uscita, Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi resta uno dei film italiani più audaci nel raccontare il destino degli uomini e il peso della memoria storica. Snobbato a Cannes 2001 e subito dopo difeso da una parte rilevante della critica, il film continua a imporsi come un’opera radicale: rifiuta la spettacolarità della guerra e, invece di celebrare le battaglie, ne osserva il crepuscolo, il punto in cui la Storia smette di essere leggenda cavalleresca e diventa macchina fredda, tecnica, disumana.
Olmi sceglie un frammento minimo: gli ultimi sei giorni di vita di Giovanni dalle Bande Nere, capitano di ventura al servizio di papa Clemente VII, nell’inverno del 1526. Mentre i Lanzichenecchi di Carlo V scendono verso Roma, Giovanni tenta disperatamente di rallentarne l’avanzata nelle pianure fangose tra Mantova e Ferrara. Il film segue il condottiero tra marce estenuanti nella neve, attese infinite, consigli di guerra pieni di sospetti, ricordi della moglie e del figlio, apparizioni dell’amante mantovana che non riesce mai a raggiungerlo davvero. Tutto converge verso una ferita “moderna”: un colpo di falconetto, nascosto dietro un muretto, che gli lacera la gamba e ne decreta l’agonia.
In questo gesto c’è il cuore del film: le nuove armi da fuoco non cambiano solo il modo di combattere, ma ribaltano l’idea stessa di guerra. Il combattimento corpo a corpo, l’avversario affrontato a viso aperto, il codice d’onore che regolava duelli e alleanze appartengono a un mondo che sta tramontando. Il cavaliere non è più un individuo che misura la propria forza contro quella del nemico, ma diventa bersaglio anonimo di un colpo sparato da lontano. L’armatura che si sbriciola sotto i cannoni, il cavaliere ridotto a sagoma su cui testare le bocche da fuoco, la maschera senza volto all’inizio del film: sono tutte immagini che raccontano un passaggio di epoca in cui l’uomo comincia a diventare davvero “carne da cannone”.
Olmi insiste su questa trasformazione con una messa in scena di rara coerenza. La fotografia di Fabio Olmi scolpisce paesaggi invernali desolati, campi brulli che ricordano il Calvario, interni in penombra dove la luce sembra filtrare da affreschi e pale d’altare. I volti – quasi tutti di attori poco noti – hanno qualcosa di ritrattistico, come se uscissero da un quadro cinquecentesco: visi pallidi, sguardi febbrili, corpi appesantiti dalle armature brunite. Ogni inquadratura rimanda a una tradizione figurativa – da Holbein a Mantegna, da Paolo Uccello alle visioni mistiche di Tarkovskij – ma senza compiacimento museale: è un cinema fisico, che sente il freddo, il fango, il peso del metallo e del legno.
Allo stesso tempo, Il mestiere delle armi è un film profondamente politico. Mentre Giovanni combatte, sopra la sua testa si muove un mondo di corti, alleanze, tradimenti. Il duca di Ferrara vende i propri cannoni al nemico in cambio di titoli e matrimoni dinastici, il duca di Mantova apre i ponti al passaggio delle truppe imperiali, i potenti si scambiano lettere e promesse mentre i soldati muoiono nelle campagne. Olmi mostra come il destino degli uomini si decida tanto nelle stanze dei politici quanto sul campo di battaglia: la guerra è già modernissima nel modo in cui sacrifica i singoli a vantaggio di equilibri di potere sempre più cinici.
Giovanni dalle Bande Nere è così insieme eroe e vittima. Educato a un’idea nobile della guerra – fedeltà alla parola data, rispetto per l’avversario, coraggio fino in fondo – è l’ultimo rappresentante di un codice che non ha più spazio nel nuovo ordine. La sua ostinazione nel salutare il nemico, nel chiedere scontri “leali”, nel rifiutare compromessi, lo rende una figura quasi cristologica: un “Redentore mancato”, abbandonato da tutti proprio mentre la Storia decide di voltare pagina. La sua lunga agonia, filmata senza melodramma ma con una freddezza quasi clinica, diventa la parabola di un mondo che si spegne senza gloria.
Accanto ai condottieri e ai principi, però, Olmi non dimentica mai gli esclusi dalla storia: contadini che osservano attoniti il passaggio delle truppe, donne e bambini che cercano di sopravvivere nelle campagne devastate, soldati che si scaldano bruciando le panche di una chiesa e persino un crocifisso. Come ne L’albero degli zoccoli, lo sguardo del regista resta fedele agli umili, a chi subisce le decisioni dei potenti senza poterle influenzare. Non è un caso che il film si apra e si chiuda sul funerale di Giovanni, incorniciando in pochi giorni un intero sistema di valori al tramonto: la circolarità del racconto sottolinea che ciò che vediamo è solo un frammento, una sineddoche di una tragedia molto più ampia.
Questo film italiano è anche una riflessione sul rapporto fra memoria e rappresentazione. Le epistole lette in macchina, le didascalie che indicano nomi e date di nascita e morte, i volti che sembrano uscire da un libro di storia, trasformano il film in una sorta di “canto all’Italia” disincantato: un modo per ricordare che le guerre non sono mai solo eventi militari, ma snodi che plasmano la politica, i confini, perfino il linguaggio con cui raccontiamo il passato. Olmi mostra la nascita della guerra moderna, ma al tempo stesso suggerisce che dietro ogni innovazione tecnica – ieri i falconetti, oggi armi sempre più sofisticate – restano corpi vulnerabili e biografie spezzate.
A oltre vent’anni dalla sua uscita, Il mestiere delle armi continua a parlarci proprio per questo: perché non si limita a rievocare un episodio del Cinquecento, ma interroga il presente. Ci costringe a chiederci quanto siamo cambiati davvero, quanto la politica continui a usare gli individui come pedine e quanto la memoria della guerra rischi sempre di scivolare verso l’astrazione, dimenticando i volti, i gesti, le scelte concrete. Nel raccontare la fine di un condottiero, Olmi mette in scena il momento in cui il destino degli uomini viene piegato dal peso della Storia, e ci ricorda che il modo in cui scegliamo di ricordare – o di rimuovere – quelle svolte è, ancora oggi, una responsabilità collettiva.
Leggi anche: A oltre 40 anni dalla sua uscita, questo film italiano resta una delle opere più audaci e poetiche sulla memoria della guerra