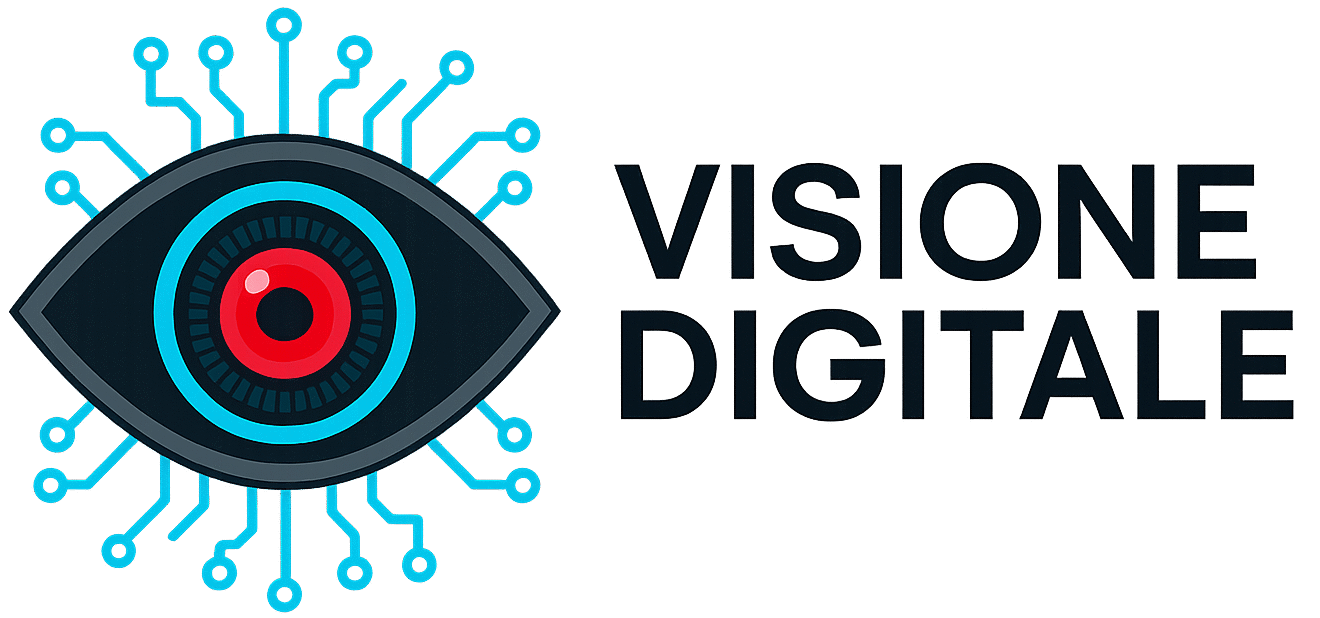Girato nell’estate del 1969 e trasmesso dalla Rai nel 1970, La strategia del ragno è il film in cui Bernardo Bertolucci trova una voce nuova e, insieme, inaugura un’idea di racconto che ridisegna il rapporto fra memoria, identità e politica. In Italia passa quasi in sordina, pensato per la televisione e perciò subito “spiazzato” dal piccolo schermo; all’estero invece conquista critici e cinefili. A rivederlo oggi, è l’opera che apre davvero la modernità bertolucciana: la prima alleanza con Vittorio Storaro, la riscrittura borgesiana del mito, la messa in scena come labirinto in cui il passato si replica e si falsifica.
La storia segue Athos Magnani, che arriva a Tara, pianura emiliana sospesa nel tempo, per sciogliere il mistero dell’eroe antifascista che portava il suo stesso nome. In paese tutto parla del padre: targhe, statue, racconti. Ogni cosa sembra un set già apparecchiato, ogni gesto una ripetizione. È la chiave del film: il figlio ripete l’esperienza del padre, fino a confonderne i contorni, come davanti a uno specchio che moltiplica le immagini senza restituire mai la verità. Bertolucci, che viene da Pasolini e guarda a Godard, innesta sul racconto di Jorge Luis Borges («Tema del traditore e dell’eroe») una detection mentale: cercare la verità significa perdersi in una rete di segni, di versioni, di scene “teatrali” che si rimettono in moto a ogni sguardo.
Formalmente, La strategia del ragno è una rivelazione. Con Storaro, Bertolucci lavora sul movimento e sulla profondità di campo come strumenti drammaturgici: carrelli laterali che guidano e sviano, campi lunghi che rifiutano il primissimo piano televisivo, inquadrature che incorniciano l’immagine dentro porte, finestre, colonnati. La luce scivola in un blu crepuscolare che sembra uscito dai quadri di Magritte, mentre i titoli di testa sulle tele di Ligabue annunciano un realismo febbrile, animale. È cinema “in minore”, dice il regista, ma proprio per questo radicale: la provincia diventa continente mitico; il Po è insieme Nilo e Mississippi; Tara è Parma e insieme un’idea di Italia che vive di riti e di rimozioni.
Il film lavora su due figure iconografiche che lo attraversano come un filo: lo specchio e il labirinto. Lo specchio è il doppio Athos (Giulio Brogi interpreta padre e figlio), è la città che riflette un’icona fino a svuotarla, è il gesto replicato che non coincide più con l’originale. Il labirinto è la struttura narrativa: flashback che non spiegano ma deviano, tempi che si sovrappongono nella stessa inquadratura, passato e presente che entrano in scena insieme. La memoria non illumina: complica, falsifica, costringe a “recitare” una storia finché quella storia non diventa l’unica possibile. Il teatro di Tara – con Verdi che risuona come partitura del complotto – è il cuore di questa messa in scena collettiva: un popolo che ripete, senza saperlo, un copione scritto per trasformare un uomo in un mito.
Dentro questa macchina di immagini si muove Alida Valli, figura elegiaca e ambigua, e si disegna una riflessione politica che va oltre l’aneddoto. Bertolucci interroga il culto dell’eroe e la necessità (o illusione) dei miti fondativi, mette in quadro il desiderio di “uccidere i padri” e l’impossibilità di farlo davvero. La stazione che apre e chiude il film – luogo dell’attesa, del tempo laterale – è l’emblema di un blocco storico e mentale: i binari invasi dalle erbacce raccontano un Paese che fatica a partire, un figlio che non può andarsene perché il passato lo trattiene.
Prodotto dalla Rai quando il regista, reduce dal naufragio di Partner, decide di usare la televisione per fare un film “da cinema”, La strategia del ragno è anche un gesto produttivo d’avanguardia: il prototipo di una stagione in cui il servizio pubblico sostiene opere autoriali destinate a durare. Che nel 1970 in pochi se ne siano accorti non sorprende: era un oggetto anomalo, tutto totali e campi lunghi, in aperta polemica con le regole del piccolo schermo. Ma è proprio lì, in quell’ostinazione formale e teorica, che il film ha cambiato il nostro cinema: ha insegnato a raccontare la memoria come invenzione, a fare della messa in scena un’idea, a trasformare la provincia in un luogo del pensiero. Oggi, mezzo secolo dopo, Tara continua a esistere. E il suo enigma, più che risolto, è diventato un modo di guardare.
Leggi anche: Questo film italiano cambiò per sempre il modo di fare cinema. Ma pochi lo ricordano